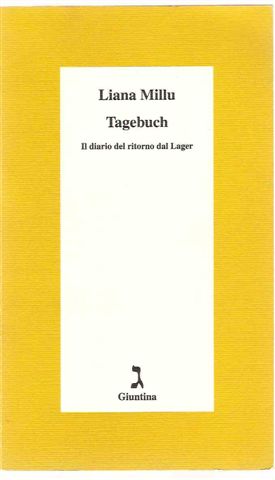
Rileggere, con Ottavia Piccolo e Piero Stefani, TAGEBUCH –Il diario di ritorno dal Lager di LIANA MILLU
Ed. Giuntina (Collana Shulim Vogelmann, 2006) pp. 103
Meclemburgo (Germania), inizio maggio 1945.
Una giovane donna -ebrea italiana-, già prigioniera ad Auschwitz-Birkenau per un anno, da poco liberata, si aggira nei locali di una fattoria, abbandonata dai proprietari nel tumulto degli eventi. Mentre l’andirivieni di soldati, ex prigionieri, lavoratori coatti si concentra tra cucina, cantina e cortile, l’attenzione della donna è attratta da una stanza che ella indovina essere stata il soggiorno dei padroni di casa. Mentre avanza con cautela sul pavimento ricoperto da detriti, con mobili fracassati, una radio sfondata…..ecco, all’improvviso, la giovane, che risponde al nome di Liana, vede, in tutto quel disordine, una matita. Da oltre un anno non ne toccava una, anche se, nel Lager, ne aveva viste, eccome, di matite: tra le dita affusolate del Dr. Mengele, ad esempio, o in mano alle SS o alle Kapò che, ogni mattina e sera, controllavano con scrupolo, sui loro taccuini, il numero dei "pezzi". Ma erano matite del Lager, per questo prive di una loro autentica essenza, astratte per così dire. Questa, invece, era una matita vera; per la sua concretezza; da guardare, maneggiare, usare.
Liana, nata circa trent’anni prima a Pisa, orfana ben presto di madre, aveva sempre avuto la passione per la scrittura, tanto da collaborare, fin da giovanissima, con il quotidiano livornese il Telegrafo, sul quale firmava gli articoli come Millu, modificando il cognome originario, Millul. Conseguito il diploma magistrale, aveva insegnato nelle scuole elementari della zona di Volterra, senza tuttavia lasciare il giornalismo. Cacciata dall’insegnamento a seguito delle leggi razziali fasciste, dopo un breve periodo trascorso come istitutrice presso una famiglia ebrea fiorentina, si era trasferita a Genova (la sua città di adozione, in cui è vissuta e morta, un paio di anni fa), dove aveva condotto un’esistenza tormentata, esercitando diversi mestieri, ma riuscendo anche a pubblicare un paio di racconti, con lo pseudonimo di Nàila (anagramma di Liana). Entrata nella Resistenza dopo l’8 settembre 1943, nel marzo 1944 venne catturata a Venezia (da italiani! Così si legge, con sgomento, nel Libro della Memoria di Liliana Picciotto Fargion) e deportata ad Auschwitz, dove rimase un anno, indi, con l’avanzare del fronte verso Ovest, fu condotta nel campo di concentramento di Malkow, presso Stettino. La liberazione, come detto, giunse ad inizio maggio.
Con la matita in mano, Liana sente un insopprimibile desiderio di scrivere: se vi fosse riuscita, quella sarebbe stata per lei la prima giornata di libertà autentica. Continua a rovistare qua e là, senza separarsi dal suo prezioso….reperto. Quasi subito, meraviglia! Un libretto rilegato in finta pelle, le pagine bianche, intonse, cinquantasei fogli di carta spessa, non rigata; in un angolo vede scritta, in caratteri gotici dorati, la parola Tagebuch (Diario). Come per una sorta di riflesso condizionato, ma con l’animo pieno di emozione, il cuore che batte forte, ella scrive, sulla prima pagina, la sigla del suo nome, Lim, più volte, con una gioia sempre maggiore; la gioia data non solo dalla certezza di essere ancora in grado di scrivere, dopo l’abbruttimento del campo di sterminio, ma anche di poter vivere una gioia autentica, pulita, come lei dice, non la "soddisfazione bruta della sopravvivenza".
Da quel giorno, per i tre mesi in cui rimane in Germania, fino al ritorno in Patria, l’1 settembre 1945, passando da un ospedale all’altro, da un campo di raccolta all’altro, ella scrive su quel diario, utilizzando quella matita. Il rientro in Italia non è facile; solitudine e incomprensione altrui lo caratterizzano.
Per alcuni decenni il Diario non ha una destinazione. Lei a volte ne rilegge, talora quasi incredula, dei brani, sovente quegli appunti, chiamiamoli così, costituiscono base di partenza per riflessioni ulteriori; riflessioni che prenderanno corpo nelle opere più conosciute, come Il fumo di Birkenau o I ponti di Schwerin.
A metà degli anni Ottanta, Liana consegna il Diario a una persona di sua fiducia, il Prof. Piero Stefani di Bologna, biblista ed esperto di Ebraismo, con l’impegno di custodirlo, ma di non leggerlo, né pubblicarlo, se non dopo la morte di lei. Lo studioso mantiene fede alla promessa. Il Diario diviene, come lui stesso scrive, una sorta di reliquia nella sua casa.
Liana muore, novantenne, all’inizio del 2005.
Nel 2006 il Diario è pubblicato da Giuntina, col suo nome originario, Tagebuch.
Il testo vero e proprio è preceduto e seguito da due testimonianze, già pubblicate tempo addietro: nella prima l’Autrice racconta la sorte della "famosa " matita, rinvenuta nella fattoria abbandonata, donata molti anni dopo all’amico Primo Levi; la seconda è incentrata sui mesi successivi al rientro di Liana in Italia, con le conseguenti incomprensioni, la superficialità, pure dei parenti, l’ottuso burocratismo degli uffici pubblici (le sembrava di essere ancora il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau!) e dei colleghi giornalisti cui si rivolge, nella dura ricerca di riprendersi la propria vita. Momenti durissimi, in cui la solitudine e lo sconforto sembrano avere il sopravvento, al punto che, un giorno, meditò perfino di suicidarsi, buttandosi sotto un treno.
"…..mi salvò la pioggia. La pioggia e l’indomabile forza della giovinezza. La pioggia o -come mi disse una volta un religioso- la vigile mano di Dio. Non lo so".
Nell’ambiente raccolto della Sinagoga di Bologna, stamani, in un gruppo di persone attente e partecipi, ho riletto e meditato ancora Tagebuch, in compagnia di Piero Stefani e di Ottavia Piccolo, una delle personalità più intense del nostro teatro.
Il primo, che è il curatore del libro, oltre che una sorta di…esecutore testamentario di altissimo livello, ha tenuto a sottolineare come l’originalità di questa, solo apparentemente, modesta opera stia anzitutto nella sua natura di testo del "subito, del presente", scritto non ad una certa distanza temporale dagli avvenimenti, ma che prende vita al verificarsi degli eventi stessi. Lo sbandamento immediatamente successivo alla liberazione, la ricerca spasmodica del cibo, il vagare di ospedale in ospedale, sono resi dall’Autrice, pur nelle forme sintetiche di brevi annotazioni (a volte ella ricorre perfino alla stenografia), con una grande forza espressiva.
Ottavia Piccolo è impegnata a Bologna, proprio in questi giorni, nella rappresentazione di Stefano Massini, Processo a Dio, che mette in scena un immaginario processo all’Altissimo, responsabile, secondo la famosa attrice Helga Frisch (interpretata dalla Piccolo) delle infinite atrocità inflitte nei secoli al Popolo ebraico, fino alla Seconda Guerra Mondiale. La scena del processo si svolge in una sorta di stanza magazzino del campo di Maidanek (ormai liberato dagli Alleati) e vede, come ogni processo che si rispetti, accusa, difesa e giuria.
Forte, oltre che della sua indiscussa professionalità, anche di questa esperienza così coinvolgente, Ottavia ha dato voce alle pagine di Liana riuscendo a operare con la scrittrice una tale identificazione, al punto di diventare, agli occhi di noi presenti, un tutt’uno con lei.
Ottavia /Liana ci ha preso per mano e ci ha reso vivi agli occhi e al cuore i diversi tipi umani fissati qua e là nel Diario, ci ha reso partecipi della notevole capacità di introspezione psicologica di cui ella è capace: a volte commossa, a volte sarcastica -impossibile dimenticare le pennellate con cui tratteggia la figura, ad esempio, del Dottor Mager-, a volte quasi spietata, specie nei confronti di se stessa. Il suo linguaggio è immediato, vivido, lo stile è quello del parlato, talvolta con intercalari del dialetto genovese (Segnur Segnur), per dare maggior forza all’espressione
Le angosce, le paure, anche quella della morte (il "grande valico", come lei la definisce), il timore di non essere più in grado di ritornare ad un’esistenza normale, i ricordi del Lager che di colpo riaffiorano, il rapporto difficile con un uomo, Nino, che le sta vicino in quei primi mesi di libertà, e al quale dirà addio al momento del ritorno nella "dolce Patria" (ironia nei confronti dell’Italia, dalla qual si sente tradita)……sopra tutto questo, tuttavia, si fa strada, prepotente, al di là di ogni disillusione e nichilismo, un desiderio, una forza di vita, che ha la meglio sui momenti più tremendi e cupi, su quell’irrigidimento e quella repulsione alla lotta cui era stata costretta nell’anno di prigionia. Esigenza di "lamentarti e azzuffarti e gridare, dare una valvola di sfogo all’ira e al dolore" per far sentire a te e agli altri, che ci sei, viva, per riappropriarti delle "amiche cose".
Un pagina di alto valore poetico, di pietas umana, è la scena della stazione. Vale la pena di riportarla.
"Il piccolo atrio è pieno di giovanotti ebrei, robusti, dall’aria sicura….E in un angolo, vicino alla biglietteria, un soldato tedesco……..potrà avere poco più di vent’anni. E’alto, quadrato, con un viso rotondo, ma di una rotondità che tradisce ora lo smagrimento….L’uniforme è ingrinzita, sporca…E’ in tutta la sua persona, nell’abito come nel corpo, la stanchezza greve della disfatta, quasi uno sbalordimento doloroso…..Gli altri non si curano di lui, egli non si muove…solo di tanto in tanto, getta su di loro lo sguardo sfuggente di una bestia catturata e impaurita, lo sguardo del cane che aspetta il colpo…..E io penso: odio quest’uomo? Potrei….godere nel vederlo maltrattare, nel vederlo umiliare? Penso e mi dico ‘lui’ no. Uno no. Perché quest’uno posso osservarlo e comprendere l’infinita stanchezza, l’infinita umiliazione, perfino la bestiale paura. Per me latina una creatura umana non potrà mai diventare un pezzo, uno ‘Stück’. Per condannarli dovrebbero essere molti, diventare cioè astrazione. E le astrazioni si possono condannare e odiare con indifferenza o con piacere".
