[Segue 23 aprile]
Ritorniamo sui nostri passi per sostare all’ora di pranzo nella luminosa Cesarea Marittima, che già conosciamo dal viaggio del 2009 e al cui Diario rimando [1] . Qui mi limito a sottolineare ancora la notevole importanza, per la tradizione cristiana, di Cesarea, divenuta, già agli albori della Chiesa, sede vescovile. Gli Atti degli Apostoli parlano in modo diffuso della località. Al cap. 10, ad esempio, si narra di un soldato del presidio militare romano, Cornelio, il quale riceve da Pietro la prima catechesi e dunque diventa il primo credente pagano dell’era cristiana. A tale proposito Pietro riflette così: “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a Lui ben accetto” (Atti: 10, 34).
Altro personaggio collegato a Cesarea per diverse circostanze è Paolo.Tra l’altro,dal porto della città egli s’imbarcaa sbarca in occasione dei suoi viaggi missionari. Qui, poi, essendo cittadino romano, viene processato e da Cesarea, dopo esservi rimasto due anni, partirà per il processo definitivo e il martirio a Roma.
Altre figure notevoli, tra le altre, sono il grande teologo alessandrino Origene, che vi fondò un’importante scuola biblica, e il primo storico della Chiesa, Eusebio di Cesarea (entrambi del III secolo e.v.).
La sosta per il pranzo è in un incantevole locale all’aperto proprio di fronte al mare.
Ci sediamo attorno ad un paio di lunghi tavoli per gustare cibi semplici e ricchi di sapore, come variopinte insalate, olive succose, nere e verdi, hummus accompagnato da soffice pita e una specie di piadina romagnola resa molto appetitosa da uno strato, in superficie, di ragout di carne, quanto mai evocativo.
Immortaliamo la piacevole pausa con numerose foto.
Poco dopo la partenza il nostro pullman viaggia sulla bella superstrada n. 6, intitolata a un Padre della Patria, Itzhak Rabin, in via di completamento nella sua parte meridionale: attraverserà tutto il Paese, da Nord a Sud.
Il tempo trascorre veloce.
Ora abbiamo la cosiddetta “Linea Verde” poco sopra di noi. La linea di demarcazione è facilmente riconoscibile dalla vegetazione impiantata ad opera degli israeliani dopo la conquista di questi territori in seguito alla Guerra del 1967. La strada è caratterizzata da lievi curve che accarezzano colline dove sorgono paesi risplendenti alla luce del primo pomeriggio.
Ecco il villaggio arabo/cristiano di Abu Gosh (conta circa 5000 abitanti ed ha sempre fatto parte dello Stato di Israele), simpatica meta turistica, di antichissima origine. Nel periodo biblico il suo nome era Kiryat Ye’arim, un centro cerimoniale dove venne collocata l’Arca dell’Alleanza, prima di essere trasferita da Re David a Gerusalemme (Primo Libro delle Cronache: 13, 5-8). In memoria di questo rapporto con l’Arca, già in epoca bizantina vi venne edificata una chiesa dedicata a Maria, la quale ha, tra i suoi appellativi, appunto quello di Foederis Arca (Arca dell’Alleanza).
Una tradizione cristiana di origine medievale identifica Abu Gosh con Emmaus, il luogo in cui Gesù si rivelò dopo la Resurrezione a due discepoli (Lc.: 24, 13-35). Notevole poi uno stupendo monastero benedettino, ben conservato, d’epoca crociata, tuttora visitabile.
Nota di colore: in Israele il villaggio è anche conosciuto come “capitale dello hummus”, servito nei diversi locali in varie maniere ed arricchito da spezie.
Ai lati della strada vediamo alcuni veicoli militari -qui conservati come memoria storica- risalenti all’epoca della Guerra di Indipendenza del 1948, il cui compito era di portare aiuto a Gerusalemme assediata. Si trattava di automezzi, per così dire, sandwich perché venivano coperti di lamiera, al fine di evitare che fossero colpiti dalle forze militari giordane.
In questi luoghi aveva sede la Brigata (meccanizzata) Harel, comandata da Itzhak Rabin, cui è intitolato pure il grande bosco davanti al quale passiamo.
Ecco, ma purtroppo non possiamo fermarci, il suggestivo monumento a David Daniel “Mickey” Marcus (New York 1902-Abu Gosh 1948).
La storia. Fin dai primi giorni di vita dello Stato ebraicomolti volontari arrivarono dall’estero per difendere Israele. Essi costituirono una brigata chiamata Mahal, un acronimo per “Volontari dall’estero per Israele” (mitnadvim mihuz laaretz).
Arrigo Levi, ebreo modenese, tra i nostri giornalisti più illustri, un testimone profondo e vivace degli eventi svoltisi del Novecento, il quale, giovanissimo, combatté per l’indipendenza di Israele inquadrato nella gloriosa Brigata del Neghev, racconta la sua esperienza nell’ultimo saggio, ricco di spunti e fecondo di riflessioni, anche a proposito di Israele e dei rapporti di questo con la Diaspora[2] .
Il più celebre tra questi generosi volontari fu il colonnello statunitense David Daniel Marcus. Poche note su questa coraggiosa figura, la cui vita fu tanto breve quanto densa di significato. Nato a New York da una modesta famiglia ebraica originaria della Romania, Paese dal quale era fuggita per il dilagante antisemitismo, diplomato presso l’Accademia di West Point, avvocato, nella Seconda Guerra Mondiale David aveva partecipato allo sbarco in Normandia e successivamente visto con i suoi occhi gli orrori dei campi di sterminio. Fino a quel momento egli si era considerato un ebreo del tutto assimilato, orgoglioso della propria nazionalità americana. Non era affatto sionista; anzi considerava in modo negativo l’idea di dar vita ad uno stato ebraico; ma il tremendo shock che produsse in lui la visione di Dachau, lo convinse che la fondazione dello Stato di Israele fosse l’unica salvezza per i suoi correligionari.
Nel gennaio 1948 giunse in Palestina con il nome di “Michael Stone”, dopo aver rinunciato al suo grado di ufficiale nell’esercito statunitense (tutto questo per non creare imbarazzo nei rapporti USA/ Gran Bretagna). Partecipò alla battaglia per Latrun, quindi progettò una strada alternativa attraverso le colline di Gerusalemme, allora assediata dagli eserciti arabi. Il tracciato divenne celebre come Burma Road (la Strada Birmana), dalla pista usata dagli Inglesi durante la Guerra per i rifornimenti alla Cina occupata dai Giapponesi. La Strada Birmana, costruita con grande abnegazione dai civili israeliani sotto la costante minaccia delle truppe giordane, consentì ai primi di rompere l’assedio a Gerusalemme, di far giungere armi e munizioni alla città e di mantenere il controllo dei quartieri ebraici di Gerusalemme Ovest. A seguito di tali eventi fu proclamata una tregua (9 giugno 1948).
Come la maggioranza degli Ebrei statunitensi Marcus non parlava ebraico, ma, bensì, oltre all’inglese, solo un po’ di yiddish. Poche ore dopo la proclamazione della tregua, Aluf (generale, il primo nella storia dello Stato di Israele) Stone fece una passeggiata notturna e quando una giovane guardia israeliana, non riconoscendolo, gli chiese la parola d’ordine, egli non comprendendo quanto gli veniva richiesto, non rispose. Il giovane fece fuoco e l’uccise. La salma ritornò in America scortata da Moshe Dayan e fu sepolta a West Point con tutti gli onori militari; caso unico di un militare americano, lì inumato, che avesse combattuto per un’altra nazione. Sulla lapide si può leggere: Un soldato per l’umanità. L’operato dell’eroico militare ha contribuito in modo rilevante al successo israeliano nella Guerra di Indipendenza.
Le gesta di Marcus sono state raccontate in un interessante film del 1966, Combattenti della notte, interpretato da un prestigioso cast di attori, in testa Kirk Douglas nel ruolo del protagonista.
Oggi, a Hollywood, così attenta al multiculturalismo e tanto “progressista”, una simile impresa cinematografica sarebbe di difficile realizzazione perché non in linea con gli standard del politicamente corretto.
Forse uno Spielberg, chissà, potrebbe tentar l’impresa, ma ritengo che perfino lui avrebbe serie difficoltà a far digerire in giro l’idea. Molto meglio un bel polpettone su Hugo Chavez, o magari Mahmud Ahmadinejad; vuoi mettere quanto costoro, con quell’indubbio fascino esotico, sono preferibili agli odiosi sionisti?
Diversi esponenti del mondo dello spettacolo -questo va detto, per onestà- simpatizzano per lo Stato ebraico; tuttavia sono gli “antipatizzanti”, nelle diverse sfumature, a farla da padroni, tacitando, di fatto, i primi.
Siamo ormai in prossimità di Gerusalemme.
C’è un intenso traffico e un forte dispiegamento di polizia; forse, ipotizza Angela (ma non ne è certa) potrebbe essere giunto all’improvviso l’inviato del Presidente Obama, George Mitchell, per riannodare le fila del rapporto Israele / Usa che ora non attraversa il suo periodo migliore.
“Sarà venuto a ‘rompere’ ….” Ironizza, con la consueta sincerità, Maria Pia.
Arriviamo alla Capitale da Ovest. Ecco i sobborghi di Motza, alla nostra destra, e, a sinistra, Mevasseret Tzion -un pensiero affettuoso alle persone qui residenti, a me vicine: gli scrittori David Grossman e Aharon Appelfeld; l’archeologo Dan Bahat, il giurista Eugenio Itzhak Cuomo-.
E, adiacente al quartiere di Ghivat Shaul, il maggior cimitero di Gerusalemme, Har Ha-Menuchot (Monte del Riposo).
Entriamo in città.
Passiamo sotto al ponte di Santiago Calatrava. Rispetto all’anno scorso mi sembra meglio inserito nel tessuto cittadino. Davvero evocativo quel pennone di acciaio, volto verso l’infinito, visibile da lontano, innalzato da Yoav Alon, il quale, tra l’altro, per conto del Ministero della Difesa, sta costruendo larga parte della contestatissima (specie da chi non ha -ancora- in casa il terrorismo) barriera difensiva, che ha ridotto il numero degli attentati contro la popolazione israeliana di oltre il 90% -opera che il tuo istinto vorrebbe vedere sparire all’istante, ma necessaria, come certe cure mediche magari durissime per l’organismo, ma salvavita-. La chemio di Israele.
Dall’intenso traffico veicolare e di persone percepiamo una febbrile attività in attesa della grande sosta dello Shabat. In onore del sabato tra poco le donne accenderanno due candele, ricorda Angela; anche lei, appena saremo giunti a destinazione, ci lascerà fino a domattina, per ritornare a casa, in centro a Gerusalemme, ed adempiere ai suoi doveri religiosi e familiari.
Bei condomini terrazzati, provvisti di berceaux da attrezzare a capanna in occasione della festa di Sukkot.
Ecco Rehavia, il quartiere elegante, con diversi edifici in stile Bauhaus.
Le bellissime parole di Amos Oz mi ritornano alla mente ogni volta che pronuncio la parola “Rehavia”. Sono le pagine in cui lo scrittore ripercorre il “pellegrinaggio” compiuto da bambino, ogni sabato pomeriggio, insieme con i genitori, Yehuda Arieh e Fania, dalla casa di famiglia posta nel quartiere di Kerem Avraham, a nord, verso la residenza dello zio del padre, l’illustre Prof. Yosef Gedaliah Klausner, situata a Talpiyot, nella zona sud.
“Qui, in via King George e anche nella crucca Rehavia e nella ricca greco-araba Talbiyeh, dimorava un silenzio diverso, che non assomigliava affatto a quello religioso dei sabato pomeriggio…un silenzio….conturbante…un po’ straniero, un silenzio britannico…”[3] .
Sulla parete di un edificio l’immagine stilizzata di una fiamma e, accanto, alcuni nomi scritti in ebraico: le vittime di un attentato terroristico, nei tremendi anni della cosiddetta Seconda Intifadah.
Una manciata di minuti e appare la sagoma inconfondibile del grappolo di alti prisma che costituiscono il tradizionale Solomon Hotel.
Ci accoglie un caloroso benvenuto, visibile fin dall’ingresso.
Prima di congedarsi da noi Angela ci consiglia, una volta depositati i bagagli nelle rispettive camere, di recarci al Kotel (Hakotel Hama’aravi, il cosiddetto Muro Occidentale) per vivere l’atmosfera di “entrata” nello Shabat.
Per la verità, saremmo un po’ stanchi.
Saremmo. Poiché l’indecisione dura pochi istanti: una breve…rinfrescata e via di buon passo verso la Città Vecchia. Siamo un bel plotoncino, guidato dall’infaticabile Roberto.
Attraversiamo David Hamelech, King David Street, alla sinistra c’è il celebre omonimo Hotel, e ci inoltriamo in una zona ricca di giardini e vialetti: il sole che si avvia al tramonto e le piante rigogliose sono il preludio della festa. Ecco Yemin (lett.: la mano destra) Moshe, il luogo così chiamato in onore del filantropo ebreo inglese di origine italiana (nato a Livorno nel 1784, da una famiglia probabilmente originaria di Montefiore Conca, bel paesino dell’entroterra riminese), Sir Moses Haim Montefiore, del quale ci siamo occupati in occasione del viaggio compiuto lo scorso anno. Yemin Moshe, come sappiamo, fu il primo quartiere ebraico sorto, negli anni ’60 dell’800, al di fuori delle mura della Città Vecchia, tra il Monte Sion e l’area adiacente la Porta di Jaffa. Rivediamo il Mulino (Montefiore’s Windmill), per noi familiare, espressione pittoresca dell’instancabile attivismo del personaggio.
“Nel mezzo di uno spiazzo verde di Yemin Moshe si alzava, come un fungo trapiantato da altri luoghi, un vero e proprio mulino, tentativo bizzarro del filantropo di rendere autonomi, dal punto di vista alimentare, gli abitanti della zona. Un esperimento presto fallito….poco oltre le pale, ferme da tempo immemore, si intravvedeva l’antica cittadella…”
Come nel settembre 1942, secondo il racconto di Massimo Lomonaco [4], Salomon Klein e George Montagu, così noi in questa giornata di fine aprile 2010, ci fermiamo un attimo su alcune panchine per farci catturare dalla magia della Città Vecchia, davanti a noi.
Giova rammentare che i programmi di Sir Moses, per varie ragioni, non si realizzarono; tra l’altro, il mulino non aveva vento a sufficienza per funzionare! L’ospedale vagheggiato restò nei progetti di Sir Moses; furono sì costruiti una ventina di appartamenti, ma pian piano il villaggio andò in rovina. Durante la Guerra di Indipendenza del 1948 Yemin Moshe divenne per l’esercito clandestino ebraico un punto di notevole importanza strategica, volto a impedire alla Legione Araba di sfondare a Gerusalemme attraverso la Porta di Jaffa.
Dopo l’armistizio del 1949, esso divenne una sorta di terra di nessuno, spesso bersaglio dell’artiglieria pesante giordana. Yemin Moshe si trasformò in un luogo spettrale, pieno di rovine, sterpaglie e incuria, abitato, a dire il vero saltuariamente, da persone prive di fissa dimora.
Com’è noto, qui passava la linea di confine tra i settori giordano e israeliano della città nel periodo 1948/1967; e dal settore giordano si sparava periodicamente sulle zone abitate dagli israeliani.
In occasione di una prossima visita a Gerusalemme sarebbe interessante visitare il Museo della Città divisa; lo riterrei istruttivo in primo luogo per coloro che, abitando lontano di qui, vagheggiano di ridurre di nuovo Gerusalemme come Berlino pre-novembre 1989.
Dopo la riunificazione nel 1967 iniziarono grandi opere di ristrutturazione che fecero della zona il quartiere elegante che vediamo, ambito da intellettuali ed artisti.
Scendiamo per poter accedere alla Città Vecchia, senza distogliere lo sguardo dall’oro scintillante delle mura di Solimano il Magnifico. Porta di Jaffa e zona dei bazar: odori, voci, colori, vita pulsante….
In breve giungiamo al Quartiere ebraico. Turisti armati di apparecchi fotografici, numerose famiglie (ultra)ortodosse, uomini con abito nero, camicia bianca, cappello a larga tesa, tallit, donne con gonne lunghe, tanti bambini…ed un’intensa emozione perché, in un vasto spazio gremito di gente……
Finalmente in piedi e in funzione dopo 62 anni (è stata riconsacrata a metà di marzo 2010), la Sinagoga chiamata Hurva (Lett. Rudere) si presenta a noi, imponente nella sua bianca cupola, simbolo della ultramillenaria presenza ebraica nel cuore della Città Vecchia; Città Vecchia compresa nella cosiddetta “Gerusalemme est” (e che sarebbe, poi?) o “Gerusalemmest”, come scrive quello spiritaccio di Ugo Volli. La Sinagoga “Hurva” non è solo una casa di preghiera; essa è stata teatro di vicende fondamentali nella storia della ricostituzione della sovranità ebraica, sia a Gerusalemme che, in generale, nella Terra di Israele; il centro dell’attivismo ebraico per mantenere la presenza in questi luoghi. Rammento, tra tali vicende, la visita qui di Theodor Herzl nel 1898, una cerimonia di arruolamento della Legione ebraica di Ze’ev Jabotinsky, svoltasi nella sinagoga, e altri episodi, che rappresentano con forza il desiderio del Popolo ebraico di tornare alla Terra dei Padri ed attestano come l’Ebraismo non sia riducibile ad una fede puramente personale, priva di riferimenti nazionali.
Sul sito della Hurva sorgeva una sinagoga fin dal II secolo e.v., cioè poco dopo la distruzione del Secondo Tempio; nel sec. XIII l’edificio venne denominato “complesso askenazita” da Ebrei che, dall’Europa, erano “risaliti” alla loro Terra di origine. Proprio per il suo forte significato simbolico, in una città -Gerusalemme- di per sé già simbolica, la “Hurva” venne distrutta più volte dai governanti musulmani che volevano a tutti i costi impedire la rinascita della sovranità ebraica; ma gli Ebrei, implacabili nella loro perseveranza, l’hanno sempre ricostruita.
Gli ultimi episodi si sono svolti durante la guerra di Indipendenza del 1948, quando la struttura fu fatta saltare in aria dalla Legione Giordana due giorni dopo la conquista del Quartiere ebraico. Sappiamo, dalla visita dello scorso anno, che il comandante giordano riferì al suo Quartier generale: “Per la prima volta in mille anni non rimane un solo ebreo nel quartiere ebraico. Nessun edificio è rimasto intatto e ciò rende impossibile il ritorno degli ebrei”
Ipse dixit. I “cari” vicini dello Stato ebraico hanno il pregio della perenne coerenza.
Ma la zona non restò a lungo Judenrein. Il Quartiere, dopo la riunificazione del 1967, è stato, negli anni, ricostruito e, da ultimo, è stata il turno di questo monumento così importante e denso di significati. Non a caso la sua (re)inaugurazione, dopo anni di desolazione e abbandono, ha suscitato rabbiose reazioni in coloro i quali, accecati dal pregiudizio e contro ogni evidenza storica, negano, o almeno contestano, la legittimità della presenza ebraica proprio nel…centro dell’Ebraismo. Una bella cupola ebraica accanto a quelle cristiane del Santo Sepolcro e musulmane di Haram Ash Sharif e al Aqsa.
E’ dunque solo un ricordo l’arco solitario che intravidi da lontano durante il primo viaggio in Israele, nel 1996, quello stesso arco davanti al quale la scrittrice austriaca Anna Mitgutsch ambienta il primo incontro tra Dvorah, voce narrante e protagonista del romanzo La voce del deserto, con il giovane Sivan“Mi trovavo tra i resti dei muri della sinagoga Hurva, davanti all’arco più perfetto e più assurdo che avessi mai visto, e mi ponevo la domanda se l’essere sprovvisto di una funzione potesse aumentare la bellezza di un edificio” [5] . Chissà che direbbe Dvora oggi…….
Accanto alla “Hurva”, askenazita, ecco la sinagoga sefardita, la Ramban. Il nome è un acronimo per Rabbi Moshe ben Nahman, cabalista spagnolo del 1100. Curiosa la sua storia. Essa venne fondata nel 1400 in una stalla appartenuta in precedenza ad un proprietario terriero arabo, ma quando, nelle vicinanze, fu costruita una moschea -della quale possiamo vedere ancora oggi il minareto- la situazione si fece inevitabilmente dura, finché, nel 1588, gli Ebrei furono cacciati e la sinagoga trasformata in bottega (!). L’immobile tornò ad essere luogo di culto solo dopo il 1967.
Sostiamo un attimo nella Piazza, intitolata a Hurva, ricca di alberi, dove incontriamo tanti gruppi di giovani, seduti in cerchio a cantare e suonare. Vi sono pure diversi militari di leva, ragazze e ragazzi, sorridenti ma vigili.
“Per noi Gerusalemme non è un campo di battaglia, ma la meta del nostro popolo, dei credenti e di coloro che cercano la giustizia per l’uomo, la speranza per i propri discendenti. Gerusalemme è l’ideale ebraico, centrale ed eterno, anche senza idealizzarne la storia”.
Queste le parole del Presidente Shimon Peres in occasione del 43esimo anniversario della liberazione della parte della città sotto occupazione (quella sì, un’occupazione!) giordana.
Poco dopo ci affacciamo alla Spianata del Kotel.Aria di festa, lo percepiamo sbirciando verso il settore riservato agli uomini, perché alcuni fanciulli, magari venuti dall’estero, celebrano oggi la loro maggiore età religiosa, il Bar Mitzvà.
L’atmosfera, nonostante il via vai di persone, è fortemente mistica.
Mi avvicino con Franca, Rosanna, Tea e Daniela.
Non ci sono solo donne ebree a pregare appoggiate al “Muro” con le mani e il cuore. Il senso di Infinito ti prende e va oltre le fedi e le nazionalità. Dall’altra parte, sul lato riservato agli uomini, religiosi stanno salmodiando…..Il suono dello shofar si libra verso il cielo…
L’ambiente è molto curato, non assomiglia certo al luogo visitato da Elie Wiesel insieme ad un amico, poco dopo la Guerra dei Sei Giorni, desolato e cosparso di pietre. Ecco la relativa immagine (v. comunque infra, dodicesima puntata, in nota).
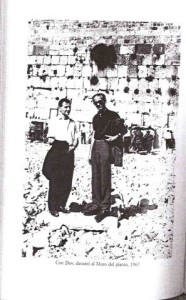
L’ambiente è molto curato, non assomiglia certo al luogo visitato da Elie Wiesel insieme ad un amico, poco dopo la Guerra dei Sei Giorni, desolato e cosparso di pietre. Ecco la relativa immagine (v. comunque infra, dodicesima puntata, in nota).
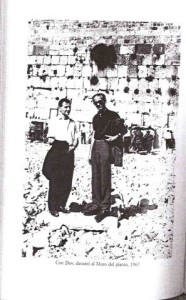
Ci riuniamo ai nostri compagni per tornare in albergo.
Costeggiamo il bel quartiere progettato da Moshe Safdie, Kfar David, ben noto, dove nutriti gruppi che festeggiano lo Shabat sembrano aspettare solo noi. Ce n’è uno, costituito da alcune famiglie sefardite, particolarmente pittoresco, con una donna che potrebbe essere una cartomante.
La Festa è sbocciata in mille fiori diversi.
[1] V. Viaggio in Israele: 22 febbraio / 3 marzo 2009, pp. 9-11.
[2] Arrigo LEVI, Un paese non basta, Il Mulino, Collana Intersezioni, Bologna, 2009, pp. 293.
[3] A. OZ, Una storia di amore e di tenebra, cit., pp. 57/58.
[4] LOMONACO M., La caccia di Salomon Klein, cit., p. 305.
[5] Anna MITGUTSCH, La voce del deserto, Giuntina, Firenze, 2008, p. 21; titolo originario Abschied von Jerusalem, Rowohlt Berlin Verlag, 1995.




